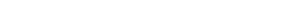Scrivere selvaggiamente
Da Reset, aprile 2011
Un ripasso allo Zingarelli non fa mai male, diceva il mio professore di italiano delle medie, ed evidentemente aveva ragione se sfogliando e cascando sull’aggettivo precario trovo ad attendermi una sorpresa. Perché oltre ai prevedibili “provvisorio, instabile, temporaneo”, scivolando giù a piè pagina e inabissandomi nei sargassi in corsivo dei secondi e terzi significati, apprendo che precario vuol dire anche cagionevole.
E mi elettrizzo.
Lo so, la parola sembrerebbe non giustificare tanto entusiasmo, ma prima di spiegarmi, ecco l’antefatto.
L’antefatto è un pranzo: eravamo a casa mia, in quattro, e si parlava, svolazzando da un argomento all’altro, senza rigore né profondità. Poi il mio amico Gabriele dice: “L’altro giorno leggevo la biografia di R.B. e la cosa che mi ha impressionato è che lui si sentiva uno scrittore anche prima di pubblicare. Nonostante in vita non abbia goduto del riconoscimento che gli è toccato da morto, continuava a scrivere, andava avanti. Io non ce la farei, si tratterebbe di lavorare perennemente al buio. Insomma, non è tollerabile sentirsi così… così… (ci ha pensato un attimo) precario.”
La precarietà. Appunto. Cominciamo da qui.
Se siete d’accordo, vorrei parlarvi di me: io non ne posso più di rockstar che si presentano in jet privato a un’intervista in cui ci ricorderanno, stringendo gli occhi e guardando oltre il loro interlocutore, che l’Africa è affamata, e osservo con sgomento queste masnade-pastello di miliardari lanciati alla scoperta delle piccole cose perché suggestionati dal corso serale di yoga. Io non sono mai andato in Africa, le mie bandiere non garriscono al vento dell’infinitamente piccolo, non faccio parte di categorie privilegiate, nessuno mi ha mai raccomandato e nessuno mi raccomanda. Ho un’utilitaria, vivo in affitto, e di quel poco o di quel tanto, sono di mia inalienabile proprietà sia il sacco che la farina. Inoltre mi sudo un contratto ad ogni romanzo, medio senza frignare tra ispirazione e sussistenza, le riviste mi pagano a peso con bilance truccate e io lotto per imbrogliare legittimamente sul grammo; quanto alla vita quotidiana, quando scarto una bolletta so che dentro non ci troverò un cioccolatino con una massima di Paulo Coelho e tutto sommato mi auguro che nei prossimi anni i miei denti continuino a comportarsi con la lealtà dimostrata fino ad ora. Dunque tutto quello che dirò da adesso in poi, lo dirò perché lo vivo in prima persona.
Io, e con me la maggior parte di quelli che scrivono, sono un precario per definizione. Faccio lo scrittore, cioè il nullatenente. Ma vorrei dire che, secondo me, è giusto così. E aggiungerei anche che essere nullatenente (cioè degente in una terra di mezzo priva di valori economici significativi) è l’unica condizione per non affezionarsi a se stessi e avere ogni cosa, e ogni cosa trasformare – in scrittura e in canto.
Brutte figure che faccio: quando qualcuno mi parla di sicurezza, mi vengono gli occhi da triglia e non so mai di cosa stia parlando.
Non per tirare in ballo il caro Ungaretti, ma tutti gli alberi e tutte le foglie della nostra fragilità non vengono meno perché una multinazionale, anche editoriale, ci sgancia una soddisfacente prebenda. Nella vita può succedere di tutto, lo dice sempre mia nonna Maria Venieri in Archetti, che guarda caso non ha mai voluto godersi le sue provvisorie brezze di felicità: ti distrai un attimo – mi fa – ed ecco che l’incantesimo finisce, tanto vale non star lì a montarsi tanto la testa. E ha ragione, perché è a quel punto, come recitano certe edificanti quarte di copertina, che “il protagonista inizia la sua discesa agli inferi, il tracollo delle certezze, l’inevitabile caduta”, cioè la caduta rovinosa a terra, dove sta la vita vera. Quindi, concluderebbe lei, siamo sempre in basso, piaccia o no. Aggiungo: uno scrittore, poi, più di chiunque altro. In tutti i sensi. E sarebbe così se anche non lo volesse. Anzi, io direi che non lo vuole, dato che non l’ha deciso a tavolino come tutto il resto, ma l’unica mia certezza è questa: lo scrittore si dibatte nel basso.
È la sua irredimibile condizione.
Essere uno scrittore non è un mestiere imposto: non lo si fa. E se anche lo si facesse, non sarebbe per sussistere materialmente, perché non lo si sceglie come altre professioni. Per quanto mi riguarda, l’idea di scrivere non è saltata fuori facendo roteare un mappamondo su cui ho piantato un indice a caso come nei film quando non si sa dove andare in vacanza; e Dio, a esser sincero, non saprei nemmeno spiegare come mi sia piovuta addosso: semplicemente, ho capito se avessi voluto imbarcarmi in qualcos’altro non mi sarebbe stato possibile. Si scrive perché non si può non scrivere. Non c’entra il genio, e men che meno qualcosa di esoterico o trascendente in tutto ciò, io non lo penso affatto, non fraintendetemi. Però è così. C’è chi parla di schiavitù, chi di vocazione.
“I poeti possono sopportare qualunque cosa”, scriveva Roberto Bolaño. Vero. I poeti sono pazzi proprio perché la vocazione non sente né caldo né freddo e le risulta estraneo tutto ciò che non riguarda direttamente il foglio bianco che ha di fronte, che è il mondo intero. Che nevichi o ci sia sole poco cambia, perché non ha occhi per vedere a un palmo dal suo naso. La vocazione è impastata di fanatismo, follia, accanimento. La vocazione piange, strilla, sbraita, ma persiste e resiste sia quando le cose vanno male che quando vanno bene. Sì, anche se vanno bene. Perché la vocazione non conosce esaudimento dei desideri, ma solo desideri. Va e non si ferma, non ha tempo per considerazioni, abbandoni o debolezze. Ma i poeti non sono superuomini, e l’ispirazione è forza ma non sempre ha la forza. Però c’è sempre qualcosa che alla fine riacciuffa lo scrittore per il bavero, eccitandolo e facendolo sentire capace di sfidare le catene himalayane. Fissazione? Maniacalità? Schizofrenia? Tutto è possibile.
Thomas Mann, in “Tonio Kröger”: “La scrittura nasce sotto il premere di una vita cattiva.” Ecco il punto: scrivere è sporco. Scrivere non è un’attività igienica né salutare. È una malattia a causa della quale si delira, si imbrattano pagine, si vaga a tentoni e al buio, cercando cosa non si sa, se non cercandola e basta. Scrivere è l’inevitabile insonnia, l’esaltazione, il sussulto; un balzo e una caduta, una catarsi e poi una nuova insozzatura. Ci si sporca con la vita, altro che. Ci si intossica. Si barcolla in una condizione di lastrico esistenziale almeno mille volte, quando si scrive un romanzo. Questo maledetto obbligo ad essere sinceri fa a pezzi qualunque convinzione e qualunque etica che barattiamo con la rispettabilità quotidiana, e ci si ritrova senza bussole in mezzo a lande deserte.
Scrivendo si comprende il guaio di essere sinceri: le bugie lasciano tutto pulito, la sincerità è sempre sporca.
Tornando al pranzo.
Ho detto a Gabriele che quando comincio a scriverla, io mi ammalo di una storia. Che quell’idea mi perseguita, mi sveglia di notte, mi accompagna durante tutta la giornata tirandomi calci, esigendo la mia attenzione e scrollandomi come uno scendiletto. Poi, a sera, mentre riempivo la lavastoviglie, ci ho ripensato e mi chiedevo: ma hai detto proprio “mi ammalo”?
Sì, l’avevo detto. E ribadisco: per scrivere come si deve – selvaggiamente – si deve essere (e alla fine si diventa) cagionevoli come dei malati. Nella salute non c’è vita, e la scrittura, al contrario della vita, sgorga dalla fragilità e si produce in quello stato convulso, sfaldato e precario, proprio della visione e dell’allucinazione. Anche del romanzo che ho appena finito di scrivere, pensavo: mi ha rincorso, mi ha preso per il collo, mi ha riempito di sberle. Ha preteso di esistere. E io dietro, inseguendolo rotoloni, soggiogato, sudato, sfatto. Non contava null’altro se non inseguire questa visione. E poi? Nessun canto di fringuelli, solo la sensazione che dopo averla braccata – dopo la convalescenza allucinata della scrittura – avrei dormito per mesi.
Insomma, qualsiasi cosa si sia capita nei miei disordinati argomenti, vorrei chiarire: non mi auguro affatto di fare la fame, anzi, il contrario – tra l’altro mi piace molto il caviale del Beluga, quello da 37.000 euro al chilo.
Ma ho una certezza, questo sì: che l’unica cosa vera e che mi rende felice, è quando, davanti al computer, metto in fila le mie parole. Per questo sarei disposto a tollerare qualunque colpo avverso, qualunque tremenda esazione, preda di un amore sgangherato, idiota, miope.
Scrivere è un infinito apprendistato, e a volte è assai aspro. Cammini sul ciglio di qualcosa, avverti la prossimità perenne del precipizio, e come tutti i malati non hai nulla da difendere... E poi forse non si arriva mai da nessuna parte, a nessuna sicurezza nemmeno poetica. Durerà tutta la vita? Non lo so. Magari no.
A volte mi chiedo: cosa penserò di me, un giorno, ripensando a tutto questo?
Si cerca la balena, si consacra la propria vita a un’ossessione, si è pronti a tutto. E poi si dubita, si prega, si bestemmia – esisterà?
Come per ogni essere cagionevole che ha fatto della debolezza la sua forza, per me conta solo il rincorrerla, ma sapete? sono stato felice.
Perché a momenti l’ho vista.
Perché, a momenti, ripensando a qualche mia pagina appena decente – ma sempre meno di quanto io mi possa illudere –, ho avuto l’impressione di essere riuscito a farla vedere anche a voi.