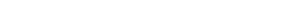Da Balzac a Piazza della Loggia, strategia della tensione, ’68. Movimento Dada e scrittori poseur: raccontati dallo scrittore meno incasellabile del panorama letterario italiano.
Bresciano con stretta di mano robusta e zigomi pasoliniani, Marco Archetti è “ne du tout fol, ne du tout sage”, come dice di sé, da un verso del poeta medievale François Villon. In effetti Archetti non pare un contemporaneo, sembra venire da un’altra epoca dove si cazzeggiava meno e si prendevano le cose più seriamente. È un complimento.
Autore unico per stile, lingua e capacità di attraversare i generi, Archetti è giunto al nono romanzo e spesso collabora col Foglio, dove si dedica a provocare con intelligenza il mondo letterario e culturale nostrano; un milieu dove il disturbo narcisistico della personalità ha fatto danni ben più gravi della crisi del 2008. Ultimo romanzo, per Chiarelettere, Una specie di vento, dove racconta le storie e le vite delle otto vittime della Strage di piazza della Loggia a Brescia, del 28 maggio 1974.
Hai presente quei servizi imbarazzanti delle Iene dove chiedono “Chi ha rapito Aldo Moro?” e qualche sventurato risponde “Hitler”? Se chiedessero chi c’è dietro la strage di piazza della Loggia?
In questo periodo sto facendo un po’ di giri per le scuole, e da un lato mi piace molto; dall’altro dipende da quanto gli insegnanti preparano i ragazzi. Proprio nei giorni scorsi un ragazzo mi ha detto che l’attentato di piazza della Loggia era stato a carico delle Brigate Rosse. Ora: da un lato lo capisco anche, perché non voglio nemmeno fare il fustigatore a mia volte stile Iene – perché detesto lo stile Iene – quindi posso comprendere che per dei ragazzi che hanno 15 anni oggi, con l’indubbia accelerazione dei tempi, parlare del 1974 corrisponda a parlare del treno a vapore. Detto questo, li comprendo ma non li perdono: perché mi chiedo anche dove vivano, chi frequentino.
La strategia della tensione e gli anni di piombo sono storia recente: che rapporto c’è oggi con queste stagioni? Debole, forte?
Non so, in generale il rapporto con la nostra storia è debole. Non lo dico solo dal punto di vista un po’ tedioso e retorico del “Chi non conosce gli errori del passato ripeterà gli errori nel futuro”. Anche perché se una cosa insegna la storia, è il contrario: che gli esseri umani non vedono l’ora di ripetere gli errori che hanno fatto, e dare agli errori nuove spoglie.
Però a Brescia la strage di piazza della Loggia è un ricordo molto fissato nella memoria collettiva della città, no?
Ne ho sempre sentito parlare a casa mia. E sì, a Brescia è un argomento di cui si parla spesso. Parlando con delle persone trovi sempre qualcuno, che conosce qualcuno, che era lì quella mattina. Poi, per carità, il rischio dell’oblio c’è. Piazza della Loggia ha già corso il rischio di diventare un grande evento rimosso, ed è stata una delle molle per cui ho voluto scrivere il libro. È un romanzo, non è un libro che ricostruisce l’iter processuale, non ne ho gli elementi: a me interessava ricostruire la vita delle persone, fare racconto e non biografia. Nel libro otto vittime si raccontano in prima persona, perché temevo che la solitudine dei nomi potesse vincere.
Hai detto che finora erano commemorate otto vittime, ma non otto persone: qual è, nel profondo, la differenza?
Commemorare non è ricordare. A volte lo confondiamo. La differenza è che inevitabilmente nella Storia quando capita un fatto di sangue, un fatto tragico come quello, vieni derubricato da essere umano e rubricato a vittima. Il che da un lato è inevitabile, eri lì; dall’altro secondo me è terribile, perché la tua funzione è solo quella di caduto e viene posto l’accento solo sull’esito e non sulle ragioni, sulla causa. Perché eri lì quella mattina? Io credo che commemorare otto nomi sia importantissimo, ma ancora più importante è ricordare perché quegli otto nomi fossero lì. Inseriti nel loro contesto storico, esseri umani come me e come te, che vivono una quotidianità, desideri, idiosincrasie, dissidi familiari, tutto quello che li riguarda: questo ce li rende improvvisamente attuali, forse eterni. Ma lo dico con senso delle proporzioni, non penso che sarà il mio libro che li renderà eterni.
Che Brescia era quella del 1974, e che Brescia è quella di oggi?
La Brescia del 1974 non l’ho conosciuta, ma l’ho sentita raccontare dai parenti delle vittime, molti dei quali era la prima volta che parlavano dei loro congiunti. Ma parto dalla seconda parte della domanda: sono tornato a vivere a Brescia nel 2013, e devo dire che sono contento di vivere a Brescia, non perché sia Parigi o New York. Perché, dai, che palle quegli scrittori che vivono “tra”…
…quelli che “Vive tra Milano e New York” o “Tra Lisbona e Albano Laziale”!
[ride, ndr] Sul Foglio ho scritto un pezzo su questa ridicola saga del “tra”, poi non sapessi quanto guadagnano… Io – dicevo – sono contento di essere tornato a Brescia, è una città di provincia con dei problemi come tutte le città, ma è una città che sta tentando di ricostruirsi un’identità e ci sta riuscendo, dopo anni in cui era molto grigia: è una città più viva, poi per carità, è una città che risente dei problemi del Paese come altre, però direi che ci sono posti ben peggiori dove stare in questo momento. Brescia è in grande rilancio. Ancorché putridamente avvelenata sia questa Pianura padana che amo anche contro me stesso…
Secondo te abbiamo perso qualcosa tra il 1974 e oggi?
Non lo so, ma non voglio neanche pensarci troppo. Questa domanda è legittima, perché viviamo il nostro tempo e anche il congedo nei confronti di altre epoche che ci precedono e siamo sempre pieni di domande sulle epoche che verranno; ma secondo me è sbagliato credere che ciò che ci ha preceduto fosse migliore o più ricco. Non so cosa abbiamo perso. Vorrei che si ritrovasse un senso della pluralità, del percepirsi come appartenenti a una pluralità. E parlando degli anni ’70, questa percezione ha anche portato ad esiti nefasti, tremendi, che non rivorrei. Pur essendo io un antinostalgico per partito preso – quindi, notare prego quanto ci sia un accento di coglioneria nel mio stesso essere antinostalgico – preferisco darmi a difetti più vitali di quello della nostalgia.
Abbiamo parlato di anni ’70 e strategia della tensione. Parliamo di un totem che quest’anno compie 50 anni: il ’68. Hai detto che il vero ‘68 è stato il ’18, quello del movimento Dada.
È un esame di maturità questa intervista! Però finalmente, anzi, grazie, di solito fanno sempre le stesse domande... In ogni caso, posto che non sono Paolo Mieli nemmeno in sedicesimo, e quindi non ho questa capacità di visione universale, onnicomprensiva, divina e divinatoria, mi accontento di essere Marco Archetti e adesso proverò ad arrancare pungolato dagli stimoli della tua domanda.
Vai.
Io non ho vissuto il ’68, ma come piazza della Loggia mi è stato molto raccontato. Dovendolo giudicare con i criteri di oggi, criteri un po’ laici, questa sensazione di messa cantata mi dà molto fastidio.
A me molte celebrazioni sembrano un po’ stucchevoli.
Credo proprio in virtù di quel che dicevo prima, che se fossi stato nel ’68 anagraficamente, probabilmente sì, avrebbe rappresentato alcune istanze in cui credo, ma avrei certamente combattuto l’alone un po’ evangelico che ha preso. È diventato una predicazione, il ’68, e come tutte le predicazioni fanatiche, a me provoca disagio.
Non riusciamo ad avere una relazione sana con quel periodo, perché?
Non si riesce ad avere un rapporto dialettico sano anche con altri snodi storici, esiste questa specie di sensazione di lesa maestà. Secondo me nuoce anche a noi, potremmo permetterci il lusso di avere un rapporto più ossigenato. E poi a volte mi sembra di notare che il ’68 ha prodotto anche una serie di convinzioni rispetto alle quali io, a dirtela tutta, sono molto avverso.
Una su tutte il 18 politico: per me quella è la crepa che porta al crollo della diga nella fiducia nelle élite di questi anni.
C’è un filo che si tiene, che io intravedo, anche quando parlo con persone, amici che votano diversamente da me, mi accorgo che c’è qualcosa che parte da lì. Questo sentimento di sfiducia aprioristica nei confronti della responsabilità individuale, mancanza della quale penso sia il vero, grande, enorme problema: quando è guasto il tuo rapporto con te stesso, cosa puoi pretendere a livello collettivo? Quando è guasto quel rapporto lì – temo – è guasto tutto.
Alla fine, rispetto al ’68, molto meglio il movimento Dada?
Non volevo proporre un confronto paritario, eh. Il movimento Dada è una cosa e il ’68 un’altra. Ma volevo paragonare gli effetti nel tempo di un processo rivoluzionario che ha riguardato anche i movimenti, uno politico e uno artistico. Io voglio celebrare in beata solitudine il centenario Dada, lì vedo una rivoluzione che è sopravvissuta agli esiti: che ha cambiato un linguaggio e la percezione, non vuol dire per forza in meglio, ma ha sancito una rottura profonda, significativa, irrevocabile, che forse il ’68 non ha prodotto. Era un confronto intellettuale e provocatorio, che sostengo, certamente, ma come provocazione, non come compiuta analisi.
Ho visto che ti chiedono sempre “Se ne va di casa all’età di vent’anni” poi ti chiedono sempre di Cuba, dove hai vissuto, per cui non lo farò. Ma invece ti chiedo: viviamo nell’epoca della distrazione: tu come fai a non cedere e distrarti?
Perché lo voglio, punto. Leggo spesso interviste a miei colleghi, anche molto più autorevoli di me, recentemente anche quel luddista di Jonathan Franzen… insomma, interviste dove dicono “Ah con tutti questi social!”. Leggo di scrittori che dicono che sul computer non tengono la connessione a internet: a me, sinceramente, fanno un po’ ridere queste cose. Io grazie alla scrittura e alla letteratura – e grazie all’educazione alla scrittura e alla letteratura – ho invece sviluppato come con nient’altro una grande educazione alla disciplina e all’attenzione. Se io in questo momento fossi anche in un bar affollato e decidessi che devo scrivere dieci pagine e finché non le ho scritte né mi muovo, né pranzo, né esco da lì, ti giuro, lo farei senza alcun problema. Credimi, è così. Volere è complicato: però uno che non vuole mi insospettisce, mi insospettisce uno che lamenta di non riuscire a volere, soprattutto se di mestiere fa lo scrittore. Per me la scrittura è anche un atto subacqueo, di indagine profonda: ma poi, soprattutto, mentre stai scrivendo, come fa a esserci qualcosa che ti interessa di più?
Facebook, Twitter, Instagram. Scrittori e social media: dovrebbero vietarglieli?
[ride, ndr] No, no, del resto se uno non si può dare disciplina da sé, a che scopo dargliela dall’esterno? La disciplina vale in quanto uno è capace di darsela, non vale in assoluto – come tutte le cose che contano qualcosa, conta quanto te la sai dare. Non dovrebbero vietarli, e a dire la verità offrono anche uno scenario divertente: vediamo cadere il velo a proposito di quello scrittore che credevamo serissimo, e poi cade, zoppica, o tonfa, davanti al primo commento politico puerile o populistoide, o alla prima zuffa infantile.
In fondo, penso, sono anche un grande safari umano, non credi?
I social media hanno slatentizzato un inconscio, che poi, per carità, è quello che è.
Hai detto che scrivi perché ti fa schifosamente felice.
Detesto gli scrittori che ci fanno pagare la loro fatica. Che ce la fanno pagare con dichiarazioni angolari sul fatto che scrivere è uno struggimento da cui non ci si riprende più. Ci sono quelli che si trovano un eremo perché solo là devono scrivere, circondati dai marabù e guardando orizzonti campestri; peraltro in questa condizione credo mi annoierei a morte, e quindi no, grazie, no!
Possiamo dirlo? Diffidare sempre degli intellettuali poseur!
Terribili. Se anche scrivere mi costasse una fatica tale da poter minare la mia salute, non lo dichiarerei in un’intervista, né te lo direi ora. Questo non perché la scrittura non sia anche un atto faticoso, perché lo è. Ma quanto più la salita si fa ripida, tanto più ha senso quello che si sta facendo. “Come sei cattolico”, mi ha detto di recente un collega – che noia mortale di commento, eh? E allora sì, va bene, sono cattolico. Non è un insulto. E infatti scrivere mi fa schifosamente felice quanto più mi affatica, quanto più esige da me, perché mi sta dando la grande possibilità di affinare il mio sguardo sul mondo, di stabilire relazioni dialettiche ed emotive, che poi sono la cosa che mi interessa di più.
Nella tua produzione hai spesso cambiato genere radicalmente: avevi paura – che so – di restare incastrato o incasellato?
Da principio avevo questa paura di auto-incasellarmi, poi ho capito che forse era un problema più mio che altrui. Adesso forse è un problema che mi pongo meno, ma del resto ho capito anche che l’assoluta spontaneità non può avere a che fare con la scrittura. Ma ti dico, a volte ho la sensazione che a volte facendo questo mestiere devi solo scegliere di quale fraintendimento morire... Adesso comincio a sospettare che essere fraintesi sia tutto, e possa essere anche il segreto.
So che ami i classici e sei critico sulla produzione attuale.
Sono critico sulla mia! Quando mi capita di leggere gli altri, i grandi scrittori, mi rendo conto che vacilla il senso di opportunità che ho del fatto che io scriva. Leggi una grande pagina e ti senti un clandestino. Se oggi leggi Balzac senti che sei uno scrittore di frodo, uno che passa di lì, uno che la racconta, se va bene un poetastro. Mi chiedo molto seriamente questa cosa: c’è una sovrapproduzione di cui anch’io in parte sono responsabile. Siamo tutti molto presuntuosi, me compreso. Siamo un po’ ebbri. Cosa ci giustifica?
Tieni molto al ritmo nella scrittura: da chi hai imparato?
Secondo me nel solito vecchio modo: leggere i grandi, comprare buoni libri, leggere i classici.
No, no, non te la cavi così. Avanti, facci i nomi!
Balzac secondo me ha una scrittura che rasenta la perfezione. Oppure uno dei più grandi romanzi italiani di sempre, che è Seminario sulla gioventù di Aldo Busi. Lì c’è un senso della lingua, una misura della lingua, e un senso della partitura che non trovo eguagliato. Dino Buzzati, integralmente. I russi, sia dell’Ottocento che del Novecento. Arthur Miller.
Claudio Giunta mi aveva detto che “Essere chiari quando scriviamo è un obbligo morale”. Tu sei d’accordo?
Certamente. Non è l’unico obbligo quando pensiamo a una scrittura non saggistica e ragionativa, ma a una scrittura narrativa. La scrittura narrativa migliore è quella complessa – ma chiara, certo.
C’è un peccato mortale quando si scrive? O più di uno?
Non scrivere, cioè abdicare al proprio ruolo, concedersi dei vezzi o delle pigrizie. Mi è successo? Sì, molte volte. Vergognoso. Quando si scrive non bisogna concedersi pigrizia, bisogna sempre sentire il cimento della pagina, il che non vuol dire stremare il lettore, ma dargli una cosa chiara ma capace di complessità, avere uno sguardo sulle cose che non sia puerile, banale, di favore, acquiescente. Billy Wilder diceva “Ho dieci comandamenti, nove dicono: non annoierai il prossimo tuo”.
So che pratichi la boxe: prova a spiegare la boxe a un alieno.
La boxe è l’epica della volontà individuale. È la comprensione di se stessi attraverso un altro. Ed è teatro. Queste tre meravigliose cose.