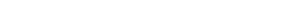Bilocale arredato
Da PreTesti, maggio 2012
Il primo appuntamento è alle otto del mattino davanti alla Coop di via Veneto.
Si presenta un ragazzo con la faccia larga e sudata. Ha il fiatone e mi fa: “Buongiorno, scusi il ritardo. Vado subito al dunque: il bilocale per cui ci ha chiamato è in questo palazzo. È abitato da un professore di origini rumene e sarà libero in due settimane. Le confermo…” scartabella fogli stropicciati, “che è arredato in ogni sua stanza.”
Gioisco: il giorno prima avevo contattato un’altra agenzia per avere dettagli su un annuncio che parlava di un bilocale arredato ed era andata così.
“C’è solo la cucina,” aveva esordito l’agente del franchising.
E io: “Scusi, allora non è arredato.”
“Be’, mi permetta, ma non è nemmeno vuoto”.
Avevo perso il pomeriggio in altre telefonate dello stesso tenore.
Forse adesso ci siamo, mi dico mentre saliamo in un minuscolo ascensore e intanto penso a Ceausescu, a quante vite consumino le case, a come quattro mura contengano romanzi.
Il trabiccolo timbra piano dopo piano e l’agente mi fa: “Spero che lei non abbia problemi per il fatto che…”
“Che?”
“Ci siamo capiti.”
“Cosa intende?”
“Be’, che il signore…”
“Il signore?”
“È rumeno.”
“E allora?”
“Non le dà fastidio?”
“No.”
“Però è una brava persona.”
“Le dico che non mi dà fastidio.”
Sbarchiamo all’ultimo piano – il sesto.
La brava persona ci accoglie sul pianerottolo: settant’anni, pantofole sformate, cardigan verde marcio. Poco incline alla socializzazione, con le sue grandi, fosche sopracciglia, ci fa cenno di entrare.
“C’è un po’ di disordine,” borbotta, “ma tanto è roba da cinque minuti, no?”
Le cattive premesse c’erano tutte, lì, a snodarsi in lungo e in largo: per esempio la moquette del corridoio era rosso uccello.
Deglutisco e mi dico: pazienta, è interamente arredato – cosa fondamentale – e poi suvvia, questo è solo l’ingresso.
Quindi alzo gli occhi: pareti del corridoio, giallo senape.
Dilato le narici. L’odore che ristagna, se potessi esprimere anch’esso con un colore, direi essere grigio tortora – ma la tortora non bisogna immaginarla viva.
Così mi guardo intorno sempre più scoraggiato. La sensazione è che quella casa abbia trattenuto secoli di ombra.
Chiedo di vedere la cucina.
L’agente si fa strada e me la mostra – piccola, piccolissima.
Poi c’è un salotto molto ampio che si apre come un ventaglio, dotato di una grande vetrata. Penso: finalmente la possibilità di un’occhiata spaziosa, vasta, panoramica.
Peccato solo che anche il salotto esalasse un’essenza di corruzione. Il balcone, a quel punto, sembra davvero l’unica salvezza.
La vista? Notevole.
Restiamo appoggiati alla ringhiera a chiacchierare un po’.
Ho già deciso che sarà un no, ma c’è ancora la camera da letto. Mi chiedo: si può ruzzolare ulteriormente in basso?
Il letto è sfatto, spanciato. Le lenzuola attorcigliate come liane, rovesciate di lato. Lo scendiletto è un tappetino nero, di plastica, da interno auto.
Mi mostrano il bagno: piastrelle bordeaux, a rombi verde acido.
Io e l’agente immobiliare ringraziamo il professore e ce ne torniamo giù, condividendo un secondo viaggio in ascensore.
È lui, l’agente, a parlare per primo. Mi fa: “Io… Be’, sa… non l’avevo mai visto, questo appartamento.”
“M-m.”
“Insomma, credo che ne dovrò parlare in agenzia perché… va bene tutto, ma… diciamolo: fa schifo.”
“Più che altro mi aspettavo qualcosa di meno triste. Ma pazienza.”
“La vista era bella, però.”
“Bella, sì. Quella, molto.”
“Ma non è che uno vive in terrazzo, giusto?”
“No, infatti”.
“…”
“…”
“Ecco, signor Archetti. Come vede, questo è il mio lavoro.”
“Non è facile, immagino.”
“È difficile.”
“Scusi, ma non trova altro?”
“Sono laureato in Filosofia.”
“Capito. Arrivederci.”
“Arrivederci.”
“E buona giornata.”
“Faccia lei.”
Il secondo appuntamento è alle quattro del pomeriggio.
Aspetto il mio uomo e passeggio sotto il portico di un condominio altissimo, costruito negli anni ’60, architettura sovietico-lombarda.
Passa una ragazza brutta che porta il cane a pisciare. Un vecchio entra al bar e si appende a una slot di donne nude. Un tizio in cappotto, seduto all’aperto a bere, sembra Enrico Maria Salerno in “Anonimo veneziano”.
La giornata è grigia. Tra poco farà buio su questi caseggiati bulgari, sulle massicciate di cemento senza speranza, sul brullo parco giochi in cui una badante biondastra fa deambulare un’anziana in tuta ciniglia color pesca.
Quand’ecco che una musica si preannuncia in lontananza.
Un martellamento da discoteca, e il mio anti-Godot balza giù dall’auto: camicia di quelle col colletto di un colore e il resto di un altro, giacca grigia, ciuffo che spiove sugli occhi, calzoni grigi anch’essi, a metà caviglia, mocassini neri a punta.
“Ciao grande, come stai?” e mi porge la mano. “Sei Archetti, giusto? Dopo di te ne ho altri sette.”
Suona un campanello e mentre saliamo mi sommerge di chiacchiere su quello che chiama il contesto, molto tranquillo, come posso vedere – lo vedo?
Quindi mi presenta la proprietaria, una sosia sputata di Jessica Fletcher, che viene ad accoglierci sul pianerottolo pigolando.
“Signora Maddalena!” sbraita l’agente abbracciandola.
La signora Maddalena lo bacia, gli da una pacchetta sul di dietro e mi chiede: “Lei si chiama?”
Ma non mi ascolta. Con un gesto un po’ amichevole e un po’ autoritario preferisce abbrancarmi e dire: “Se permette, le spiego tutto io. Dunque, questa è la cucina.”
Niente di realmente depressivo, a guardarlo così, ma risultava chiaro che i mobili erano scollegati stilisticamente; il classico tentativo di conciliazione tra avanzi eteroprovenienti.
La vecchia prosegue: “Qui c’è la lavastoviglie… Vede? Poi il suo bel lavello. E questo è il frigor. Le piace?”
“Non male.”
“Lo credo. Vede, io e mio marito ci siamo detti: perché non rendere bella una casa, anche se ci deve abitare una persona che non conosciamo? In ogni caso, conosciamoci.”
“Prego.”
“Come mai non è sposato?”
“Non so… Io… Scusi, perché lo vuol sapere?”
“Ho notato che non ha la fede. E sa, io le offro un appartamento con tutti i confòr ed è ovvio che lei debba rispondere alle mie domande.”
“Non sono sposato perché… non sono sposato.”
Il giovane agente, alle spalle della vecchia, fa segni di non poterne più, dapprima mimando uno che trasporti con una carriola i propri testicoli, quindi inscenando una sbrigativa autocrocifissione all’attaccapanni.
Allora io rilancio: “Se le può andar bene, signora, sono fidanzato.”
“Uff… Chi non è fidanzato, al giorno d’oggi?”
“Già.”
“Passiamo al salotto che è meglio.”
No, il salotto non era meglio. Tuttavia lei lo presenta così: “Questa è la sala di rappresentanza.”
Quindi tira dritto verso l’immensa portafinestra, conta fino a tre, solleva la tapparella – il coup de théâtre della visita – e fa: “Guardi qui che popò di vista. Guardi e dica sinceramente: dove la trova una vista così?”
Tutto è grigio topo. Panoramica su un parco giochi da “Decalogo” di Kieslowski e sul torreggiante, minaccioso pinnacolo di un inceneritore.
“È rimasto senza parole? Non se l’aspettava? Ah, e poi dia un’occhiata qui.”
E passa a descrivermi, di quel salotto di rappresentanza, mobile per mobile; a un certo punto impernia tutto il trallallà su una tovaglietta di viscosa rosa salmone a losanghe crema, che ricopre un mobile color martora che aveva bisogno di tutto tranne che di ulteriori insolenze estetiche.
Poi si interrompe e, come un giro di blues, torna da dove era partita: “Scusi eh… Prima ho capito male o ha detto fidanzata?”
“Sì.”
“Fidanzat-a?”
“Fidanzat-a.”
“Bene. Sennò non se ne parlava nemmeno.”
La camera da letto è arcaica, buia, satura d’etruschi afrori.
Quando la visita finisce, la vecchia dice: “Mi ha fatto una buona impressione, glielo devo dire.”
Non penso la stessa cosa, né di lei né della casa. Scendo le scale e immagino la mia vita lì – ma non posso, non me la sento.
Il giovane agente, trotterellandomi accanto, mi pressa: “Come ti è sembrata? Secondo me ti è piaciuta molto. Dimmi se sbaglio. Io non sbaglio mai.”
“Mah. Non so. Ci devo pensare.”
“Non ti è piaciuta?”
“Forse no.”
“Be’, l’avevo capito subito. Infatti, non ci crederai, ma… ta-da-dà! Ho una cosa che fa al caso tuo. Molto più di questa catapecchia.”
“In che senso?”
“Guarda, te ne parlo in via del tutto confidenziale.”
Arriviamo da basso. Fuori imperversa il classico, scoraggiante buio novembrino.
Lui mi accartoccia in un angolo e bisbiglia: “C’è questo posto… una specie di loft… In via… dunque, vediamo… via Lombroso. Una perla, l’arredamento è recente. Che dici? Come la vedi? A me puoi dirlo. Allora?”
“Non saprei. Sempre su questo prezzo?”
“Poco di più. Ma poco. Pochissimo. Però non farmi l’errore di… Insomma, tieni conto di una cosa: questo posto ti rappresenta alla grande.”
“Cioè?”
“Cioè, prendi punti. Tipo che una tipa ci entra, ti salta addosso e… zam zam! Ci siamo capiti.” Mi affibbia una pacca sulla spalla più forte di quel che avrei desiderato e andandosene fa: “Chiamami domattina, mi raccomando.”
Salta sulla Mini, fa un saluto dal finestrino, e in un energico pulsare hip hop vola via.
Il terzo appuntamento è la mattina successiva.
Con me c’è un’agentessa bionda e sbrigativa. Secca, dritta, capelli corti, vestita di pelle rossa, tacchi alti. Sui sessant’anni.
Il palazzo è nello stesso quartiere in cui sono nato.
Saliamo le molte scale e ci fermiamo davanti a una porta sottilissima di legno bianco. In cima, a sbavare di luce morta il pianerottolo, una lampadina a forma di pera. Poi guardo meglio: la porta stessa non è costituita da un pezzo unico, ma da due grandi fasce di legno tenute insieme grazie a una zeppa di compensato inchiodata di traverso e crivellata da decine di puntine da disegno. La bionda, guardando me che la guardo, inspiegabilmente seccata mentre cerca le chiavi e le fa rullare nella serratura, fa: “Se le dà fastidio, possiamo far mettere tutto a posto, eh.”
“Per fortuna l’ha detto lei. In effetti una porta così non è il massimo.”
“Intendevo la lampadina.”
Entriamo.
L’appartamento è simile a una grande camera di motel sulla statale in cui, nell’immaginario caro a certo cinema horror, si consumano delitti feroci ad opera di taciturni e rabbiosi disadattati coi capelli a spazzola.
Neon nel corridoio, che balbetta su una cucina angusta. La moquette, per dirla col Della Casa, putisce.
Il frigorifero è un vecchio frigo da roulotte incastrato in una sede che non è la propria, e inchiodato in un vano che lascia ampi vuoti laterali in cui, a una superficiale indagine, riscontro forme biologiche che non primeggiano nella tassonomia universale. Ma il gioiello è la figurina appiccicata sullo sportello, un po’ opaca e un po’ sgrattata, di Geronimo Barbadillo, Avellino, stagione calcistica 1983/84.
Il salotto ha poltrone che non solo sembrano unte, ma lo sono davvero. L’aria è quasi farinosa, zeppa di polvere.
Il bagno è diviso in due parti: in una, vasca e bidé; nell’altra, lavandino e water. Mi figuro grotteschi trasferimenti dall’una all’altra parte, talvolta reggendomi un asciugamano intorno ai fianchi, talora a brache lasse. I rubinetti perdono tutti, rintoccando il conto alla rovescia per il mio suicidio.
Poi l’agentessa mi richiama in soggiorno. Ritta vicino alla finestra, solleva al massimo la tapparella del decadente corridoio e con legnosa assenza d’ironia, aggiunge ciliegine a una torta che vede solo lei. Si bilancia su un tacco e proclama: “Le faccio notare che in questo spazioso appartamento sono ben tre, i pregi piuttosto rari altrove. Innanzitutto, il balcone.”
Pregio che però si presenta sotto le mentite spoglie del difetto: una lingua di cemento stretta e spavimentata corre dalla striscia di Gaza del cucinino fino al salotto, dove finisce in un rovinoso cumulo di ciottoli.
Secondo pregio: “Vogliamo trascurare l’aria condizionata?”
No. Anzi, trascuriamola meno dell’intonaco del soffitto e della sua lunga sindone di umido a forma di Gesù Cristo crocifisso.
Terzo: “Non dimentichi il ripostiglio!”
Il quale contiene, misteriosamente, un vecchio bidé zampe all’aria.
Mentre riabbassa le tapparelle, conclude: “Bene, andiamo sul pratico: quattro mesi anticipati, non i soliti tre – sa, la padrona ci tiene. E poi scusi, signor Barchetti, ma lei ha un lavoro?”
“Sì, certo.”
“Che lavoro fa?”
“Scrivo.”
“Dicevo lavoro.”
“Scrivo. È il mio lavoro.”
“Busta paga che lo dimostri, grazie. La padrona valuterà.”
E se ne va così, disseminando il vano scale dei suoi tacchi rimbombanti.
Resto al buio, solo, sul pianerottolo. Fuori comincia a piovere.
Tre minuti, e mi squilla il cellulare.
È ancora l’agentessa. “Signor Parchetti, ci ho pensato: niente in contrario se nella sua scheda metto in cerca di occupazione, vero?”
“Niente in contrario.”
“Se non ci sentissimo più, in bocca al lupo per tutto.”