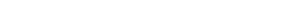Sul tuo sito hai raccontato la tua vita in modo abbastanza dettagliato, scandendola con i titoli e le date delle tue pubblicazioni. Quindi, più che chiederti conferme dei fatti, mi metterò a scavare un po’ tra i perché. Quando te ne sei andato di casa, dopo il liceo, sei rimasto a Brescia? E come mai la scelta di andartene appena maggiorenne?
Perché ne sentivo la necessità. Me ne sono andato di casa molto giovane e mi sono mantenuto facendo vari lavori, lavori che non avrei nessun problema a rifare domattina, non ritenendo la scrittura un’elezione semidivina. Diciamo che in quel momento andava bene così. Volevo essere indipendente e ci riuscivo. E poi scrivevo, di notte e di giorno, in ogni momento libero. Scrivevo e leggevo, ma senza la piena consapevolezza del perché lo facessi. Scrivevo e leggevo come uno scemo, e basta.
Cuba: questo capitolo della tua storia è appena tratteggiato nella biografia. Chi è (sia pubblicamente che per Marco Archetti) Omar Pérez? Come hai vissuto a Cuba e come ti ha cambiato quel periodo?
Il periodo cubano è stato il periodo più bello e più brutto della mia vita. Ho conosciuto molte persone, lì, tra cui Omar, poeta, saggista, scrittore, uomo dotato del carisma del pensiero. È stato un fratello. Ma ho anche vissuto, purtroppo, i problemi dei miei amici: la galera, i ricatti, la censura, la miseria. Promettevano paradisi, da quelle parti.
A Cuba nasce “Lola Motel”, pubblicato nel 2004 con Meridiano Zero, ma avevi già scritto cinque romanzi, mai pubblicati. Cosa ti ha portato a proporre proprio quello, cioè a smettere di scrivere “in privato” per iniziare a fare sul serio? E come sei arrivato a farlo con Meridiano Zero?
A Meridiano zero sono arrivato grazie al servizio postale. Ho inviato il romanzo e mi hanno risposto. Ho pensato di proporre quello e non uno qualunque degli altri cinque perché lo sentivo più maturo. Non in senso assoluto, ci mancherebbe. Ma in quel momento era quanto di meglio potessi fare.
Da Meridiano Zero a Feltrinelli. “Vent’anni che non dormo”. Raccontaci questo salto, compiuto in un solo anno.
Sì, si trattò di un salto, è vero. Mi ritrovai, da aspirante scrittore inconsapevole, a un pranzo milanese in cui Alberto Rollo mi rivolgeva critiche e complimenti, e mi parlava di un contratto da firmare presto. La sera ho festeggiato. Con una certa immoderatezza, a dire il vero.
E “Jet Lag”?
Fu il racconto con cui ho partecipato a “Scritture giovani”, Festival letteratura di Mantova. Ci avevano dato un tema: l’Altrove. Io, che ho sempre avuto in odio i birignao, scrissi un racconto sventato e comico, ambientato in un cimitero. La morte è un altrove, no? Ad alcuni piacerà, ad altri meno. Io, prudenzialmente, evito di rileggermi.
Poi non ti sei fermato un attimo: per “Maggio Splendeva” ti sei trasferito a Roma, “Gli Asini Volano Alto” l’hai presentato a Firenze ed in mezzo ben due festival internazionali… Tre anni senza respiro. Commentaci questo triennio.
Maggio splendeva è ambientato a Roma nel 1936. È un romanzo che mischia Storia e fantastico, e sai, sentivo la necessità di cambiare dopo Vent’anni che non dormo, che fu molto amato ma che non volevo mi cacciasse in un cul de sac narrativo – un problema forse frivolo, ma tant’è. Andai a Roma per fare dei sopralluoghi, poi un’amica mi disse: “Restaci, no?” E ci sono restato. Poi mi sono trasferito a Milano. In un inverno cupo ho scritto Gli asini volano alto, un romanzo comico sui dieci comandamenti e su due fratelli. Quindi ho partecipato al festival internazionale di Guadalajara, in Messico. Ricordo un’intervista con Pino Cacucci e Bruno Arpaia molto divertente, e il viaggio di ritorno, in aereo, con Sveva Casati Modignani che mi raccontava le sue esperienze in Africa. Una per una.
Arriviamo al 2011: con “Sabato, Addio” dai il via ad una sorta di romanzo noir in cui il protagonista racconta in prima persona la propria vita.
Io avevo già in mente una storia come quella di Sabato, addio. Poi, un’estate, nel rileggere l’Antologia di Spoon river di Lee Master pescata a caso dalla libreria estiva di casa di un’amica, ho trovato il criterio narrativo che mi interessava. Volevo scrivere la storia di un uomo brutto e di una donna bellissima, sentimento e delitto. Come in tutti i miei libri, considero guadagnata la pagnotta solamente se riesco a far sì che il lettore non mi molli e abbia voglia di voltare pagina chiedendosi: “Cosa succederà, adesso?”
Nel 2013 pubblichi con Giunti Editore e non più con Feltrinelli. Ci puoi spiegare perché il “cambio di marchio”?
Perché succede. Si cambia lavoro, si cambia editore. Se ne trova uno nuovo, si ritorna con quello vecchio. È il valzerone consueto che balliamo tutti, al lavoro e nelle cose di ogni giorno.
“Sette Diavoli”: qui fermiamoci un attimo. Assolutamente vietato raccontarne la trama. Parliamone senza raccontarlo. Torna il tema della guerra. Perché?
Hai ragione. Il tema della guerra è spesso presente nei miei libri. Non saprei spiegarlo, però, in generale non indago a fondo sui perché delle cose che scrivo. Le scrivo, e da lì in poi, lavorano gli altri, interpretando, immaginando, sistematizzando. Io mi faccio travolgere, certo, ma passato il turbine, passo ad altro.
Egle, allora: una signora seduta in un bar che si racconta disordinatamente e che tu, passando di lì, ascoltandola, tramuti poi nel personaggio del tuo libro – esempio di come la realtà può essere spunto primitivo per poi diventare immaginazione. Come funziona la tua mente di scrittore?
La mia mente di scrittore è la mente di chiunque altro, che vede una donna e ci fantastica su. Mi succede dalla mattina alla sera, in tram, a piedi, in automobile mentre sono fermo al semaforo, ascoltando la radio. La realtà non va sprecata, le storie hanno due gambe e due braccia e sono tra noi. Io davvero, credimi, vedo le persone come romanzi ambulanti. Ognuno è felice, triste, crudele, indifferente, emotivo, altruista. Ognuno racconta qualcosa. Ognuno si porta dietro un fardello di piombo o una collezione di farfalle. Scrivere vuol dire dare un ordine a queste fantasticherie. Dar loro un senso, un capo e una coda. Una bella storia è una bella storia. Certo, esiste solo quando viene raccontata.
Egle, una donna sola, in mezzo alla fine della guerra, nel cuore di Brescia. Una donna che ha sette diavoli in corpo. Una donna che nasce al mondo già vinta, ma che non si piega mai, neanche alla fine, pur dovendo giocare con le regole di un gioco imposto. Le hai voluto bene raccontandola? Cosa ti ha dato lei che prima non avevi? Può un personaggio “dare qualcosa” all’autore che lo crea? Se sì, come? Parlaci del tuo rapporto con questo personaggio…se è stato difficile “crearlo”, quali difficoltà ti ha sollevato, quali soddisfazioni. Insomma: tu ed Egle.
Io ho amato Egle come solo, prima, Ester di Maggio splendeva. Anche Filippo di Sabato, addio, devo dire, l’ho davvero molto amato. Il fatto è che io mi immergo sempre in ogni personaggio che racconto. E ogni personaggio che racconto per me è esistito, esiste. Chiudo gli occhi ed è sempre qui. I due fratelli de Gli asini volano alto ancora mi fanno ridere, quando ci ripenso.
In un’intervista hai detto: “Detesto chi scrive per amore di se stesso e non delle storie che racconta”. Cosa hai amato della storia di “Sette Diavoli”, al punto di volercela raccontare?
Ho amato, di questa storia, la forza della protagonista. E la possibilità di raccontare una donna in prima persona, accettando, di fatto, un rischio. Ma ogni romanzo che scrivo per me è un gioco serissimo, una scommessa. Mi chiedo: riuscirò ad arrivare fino in fondo? Riuscirò a dire quel che devo dire, e a dirlo nel modo migliore? Riuscirò a dire anche, per soprammercato, qualcosa di più? Sarò all’altezza? Crollerò prima? domande e domande. Rispondo scrivendo, cioè dimenticandole.
Facciamo almeno uno scatto fotografico sul Marco Archetti “scrittore-essere umano”. Sappiamo che non scrivi seduto alla scrivania, immerso nel silenzio di uno studio arredato ad hoc: tu scrivi nella tua cucina, oppure seduto in un bar. Cos’è che ti piace tanto delle cucine e dei bar? Cosa non ti piace delle scrivanie? Scrivi a penna su fogli di carta o giri con il portatile sottobraccio quando lo fai nei bar? Hai un bar “fisso”? Raccontaci.
Delle cucine, non so, forse amo la luce, la tranquillità. Mi ci trovo bene. Comodo. Dei bar amo l’esatto contrario: il viavai, il luccichio dei bicchieri e delle tazzine, il gargarismo della macchinetta mentre fa il caffè, i giornali svolazzanti in giro e il rumore di fondo. A un certo punto posso alzare la testa, vedere o sentire qualcuno, e portarlo dentro quel che sto scrivendo – io collaboro con la realtà, mentre scrivo, non la respingo affatto. Ho un paio di bar fissi e giro col portatile sotto braccio. Scarabocchio moltissimo anche sui fogli, però. Soprattutto le strutture, le trame. Io lavoro moltissimo sulle trame. Tutti credono che io lavori sodo sul lessico o sulla forma. Be’, non è così. Lì mi viene tutto abbastanza facile, a volte, addirittura, buona la prima. Invece sgobbo come un matto sulla trama e sul ritmo. La mia vera ossessione è il ritmo. Ciò che non ha ritmo, io non riesco nemmeno a leggerlo.
Romanzi vs racconti: tu che li pratichi entrambi, prova a far luce su queste due modalità narrative, anche alla luce del recente premio Nobel per la letteratura.
Li pratico entrambi, vero, ma con una differenza: anche come lettore, mi sento più congeniale il romanzo. Non escludo tuttavia che una mattina io mi alzi e mi scopra scrittore di racconti, e magari scriva solo quelli. Il mio lavoro mi deve sorprendere, lo pretendo e faccio di tutto perché possa accadere.
Fioriscono e spuntano come funghi i corsi di scrittura creativa: servono secondo te? Cosa fa di un uomo (e di una donna) uno scrittore?
Difficile da dire. Non saprei. Di certo bisogna aver voglia di raccontare, uscire da se stessi, abbandonare lo specchio ed essere appassionati agli esseri umani. Ascoltare. Rubare. Immaginare di essere chiunque. Non chiudersi in casa. Amare. Odiare. Giocare. E fare un passo indietro.
Perdonami, ma non ce la faccio ad evitarla: perché la boxe?
Parlare di boxe per me è un invito a nozze – una volta non si diceva così? si diceva “è un invito a nozze” per intendere che fosse cosa gradita, eppure bah, io sento gente che dice sempre: “Che palle, sono invitato a un matrimonio.” Ma torniamo ai guantoni: la seguo fin da piccolo. I gloriosi anni ‘80 visti dal mio divano: Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Roberto “manos de piedra” Duràn, il grandissimo Julio César Chávez. Mio padre la seguiva. E io di conseguenza. Poi, grazie a un reportage che il Corriere della Sera mi ha fatto fare all’interno di una storica palestra di boxe bresciana ho riscoperto l’amore che si era sopito. I sacchi, gli specchi, l’ambiente angusto e un po’ lugubre, l’odore della fatica, il ring e le corde: il giorno dopo mi sono presentato per cominciare. La boxe è bellissima. È uno sport che racconta storie, che narra l’uomo, i suoi sogni, i suoi fantasmi. Per me il pugilato è resistenza e dignità, forza e fragilità, intelligenza e sportività, mistero e – per fortuna – anche semplicità.